Hotel Aspromonte

Ormai da dieci giorni, quotidianamente risalivano per quei dirupi antichi che li schernivano, inciampando continuamente, durante la marcia, negli arbusti bassi e spinosi.
Centinaia di metri più in alto la Montagna, eterna e severa, brontolava il suo fastidio ammantata di nuvole basse e gonfie di pioggia.
L’ispettore Morena imprecava tra i denti, incitando gli agenti a seguirlo in linea aperta per rastrellare più rapidamente l’intera area assegnata alla loro squadra.
Le probabilità di trovare qualcuno nascosto in quelle forre, tra i canaloni impervi ed il sottobosco, erano veramente ridicole.
Sul crinale a destra, in alto, un pastore pesantemente appoggiato al suo bastone, la coppola consunta ben calcata in testa, seguiva i loro impacciati movimenti ormai da più di un’ora, durante la quale la squadra di Morena aveva battuto non più di un paio di chilometri.
La faccia di pergamena bruna, avvizzita dal sole e ruvida di barba ispida, nascondeva gli occhi solo apparentemente assenti.
“Io gli sparerei, a quello sporco spione”, sbottò Morena.
Come l'avesse sentito, il pastore, o cosa diavolo altro fosse, stirò la ferita delle labbra in un taglio beffardo, scoprendo grandi denti selvaggi, anneriti dal tabacco.
In un momento, sembrò dissolversi, scomparendo anche all'osservazione dell’elicottero che appoggiava l’operazione dall'alto, seguendo, molto più comodamente, gli uomini impegnati in quella ennesima scampagnata.
“Lo sai perché i carabinieri quando vanno a letto mettono sul comodino…“?”
“Ehi, Morena, mi senti?”, insisté il sovrintendente.
“Sì che ti sento! Ma cosa vuoi che mi freghi dei Caramba?”
“È una barzelletta, ti dico! Mettono sul comodino...”
Uno sparo improvviso echeggiò tra gli alberi del vallone vicino, facendo appiattire a terra tutta la squadra.
Morena abbracciò, come tutti gli altri, la montagna, il naso immerso nella foresta di fili d'erba che ne ricopriva il fianco e gli orecchi percorsi dall'eco cattiva dello sparo.
“Che facciamo, accucciati per terra, Morena?”, chiese di lì a poco uno dei suoi uomini.
“Per ora salviamo la pelle”, mormorò il capo squadra, tutto concentrato nel tentativo di ristabilire il contatto radio con l’elicottero della polizia che aveva scelto proprio quel momento per svolazzare da qualche altra parte. Mai presenti quando servono, questi fetentissimi baroni dell‘aria, recriminava, urlando nel microfono della radio portatile :
”Lince tre chiama Falco, Lince tre chiama Falco..., che fantasia!”, soggiunse tra i denti.
“Dottore, sono Morena”, sbottò infine, sperando che quelli dell’elicottero lo sentissero, “qualcuno, forse un pastore, ci ha sparato addosso. Dove siete?”
Il pilota doveva essersi allarmato, perché con una brusca virata l'elicottero riguadagnò la verticale sulla squadra a terra; poi a bassa quota avviò dei giri concentrici, all'inutile ricerca di un qualche movimento strano.
“No, non c'è nessun ferito”, rispose finalmente alla radio Morena che, rincuorato del fragore delle pale del velivolo, aveva fatto rialzare i suoi uomini.
Provarono, per pura facciata, ad individuare l'origine dello sparo. Ma non ne ricavarono nulla. Chi lo aveva esploso poteva trovarsi anche abbastanza distante.
La vegetazione e le prime ombre della sera fecero il resto.
Il Ducato fuoristrada riportava mestamente a valle la squadra di Morena, quando il sovrintendente riprese:
“Allora, sapete perché i carabinieri, la sera, mettono sul comodino un bicchiere vuoto?”
"Già, diccelo perché si portano a letto questo maledetto bicchiere vuoto, e falla finita!”, l'apostrofò l'ispettore, avvilito dalla prospettiva di dover passare quel che restava della serata a stendere il rapporto sull'incidente.
"Per il caso che durante la notte non gli venga sete!”
L'area grigia
Prefazione
Un libro diverso, questo di Franco Musolino e Pasquale Romeo L’area grigia. Dove tutto è ’ndrangheta niente è ’ndrangheta.
Diverso dai tanti libri sulle mafie basati sull'analisi, più o meno completa, più o meno approfondita, di atti processuali.
Musolino e Romeo, invece, intessono un fitto dialogo per rispondere ad una domanda fondamentale: la ’ndrangheta è un’entità autonoma o fa invece «parte di alcuni aspetti del modo di vivere calabrese e ci appartiene profondamente in alcuni aspetti culturali fondamentali»?
In questo dialogo ognuno dei due Autori porta la sua formazione culturale e la sua esperienza professionale.
Franco Musolino, prefetto della Repubblica, rivendica con orgoglio la differenza fra le Istituzioni e i singoli che le rappresentano, rifiutando le critiche qualunquistiche e generalizzate. Mette in evidenza come sia essenziale che da sudditi si diventi cittadini, ma riflette pure sul ruolo di ogni singolo cittadino sulla base della sua esperienza personale e professionale a Milano e a Reggio: la città lombarda per i suoi abitanti è soggetto portatore di una carica positiva rivendicata con orgoglio, Reggio è caricata di connotazioni negative e diventa non un “soggetto”, ma solo un luogo in cui i componenti della collettività sono condannati a soffrire una condizione negativa della quale, però, quasi ci si compiace, come si coglie bene in alcune espressioni popolari «Riggiu non vindìu mai granu ... tantu simu a RRiggiu ... ».
Pasquale Romeo, medico e psichiatra, approfondisce gli aspetti socio logici e psicologici del fenomeno criminale e le sue caratteristiche di devianza sociale, sottolinea le necessità di «strumenti a cavallo tra la sostanza, la comunicazione e la psicologia» e gli effetti devastanti del nichilismo sempre più presente nella società che sostituisce i valori con i disvalori, l’uomo con il denaro.
Si tratta di un dialogo fitto e serrato, a volte difficile.
Moltissimi sono, infatti, i temi trattati ed ancor più i temi offerti alla ulteriore riflessione del lettore: il disfunzionamento del sistema sociale come premessa per lo sviluppo della ’ndrangheta, l’importanza delle vicende storiche che hanno portato le regioni meridionali a vedere lo Stato come un'entità estranea, l’individualismo esasperato ed il ruolo della famiglia, la tendenza al fatalismo, la legalità debole e la “cultura” del favore, il difetto di comunicazione Istituzioni/cittadini, il maggior peso che l’area grigia ha in una città provinciale perché è più facile l’osmosi tra i diversi livelli sociali.
E ancora tanti altri temi tra i quali, proprio per le sue possibili implicazioni di carattere generale, avrebbe meritato, forse, un approfondimento maggiore la straordinaria capacità della ’ndrangheta di “clonare” la sua organizzazione criminale nelle regioni d’Italia e del mondo in cui si realizza l’emigrazione calabrese.
Ma quello che è essenziale nel dialogo fra i due Autori, calabresi e innamorati della loro terra, è la chiarezza con cui denunziano che «la ’ndrangheta è un clamoroso alibi per coprire un colpevole disimpegno civile» e che «un ruolo fondante lo abbiamo noi, proiettando sulla ’ndrangheta tutte le nostre inefficienze, quello che non riusciamo a fare, trovando in essa un modo oscuro per non lavorare, per non impegnarsi, per dire: tutto è così e così deve essere».
Se posso fare un accenno personale alla mia ancora breve ma intensa esperienza alla guida della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ho spesso sentito, in occasione di processi per fatti gravissimi, l'invito a “non criminalizzare” una persona, un’impresa, una comunità; è la stessa logica perversa contro cui mette in guardia una delle citazioni premesse ai brevi capitoli del libro: «Spesso si lascia in pace chi ha appiccato l’incendio e si castiga chi ha dato l’allarme».
Su questo la posizione di Musolino e Romeo è chiarissima: bisogna creare una «reazione per esprimere un sussulto di rabbia, elemento principe per cambiare» una società malata che a volte si è tentati di considerare “normale”, cambiando l’atteggiamento, tipicamente calabrese, per cui «aspettiamo continuamente Godot, come nella commedia di Beckett, in maniera perversa e immobile, negando le cose positive già fatte e sottolineando solo quelle negative».
E, soprattutto, «questo non è un lavoro che possa darsi in appalto» né alla magistratura, né alle forze di polizia né a nessun altro; esso compete direttamente all'intera società.
Reggio Calabria settembre 2009
Giuseppe Pignatone
Procuratore Capo della Repubblica
di Reggio Calabria
Operazione acqua di felce

Mi volta le spalle, sprezzantemente. Non posso lasciarlo andare. Non così. Lo ammazzo! Faccio un passo in avanti, inciampo in uno sterpo, barcollo, scivolo e, quasi istintivamente, il mio indice si contrae sul grilletto della pistola. Per un attimo, solo per una frazione di secondo, mi attraversa il dubbio che forse dovrei premere ancora il grilletto. Poi, il colpo secco dello sparo spezza il silenzio del bosco e rimbalza, interminabile, tra le felci e gli alberi che fanno da corona alla radura, in un’eco prolungata che mi sorprende. Quasi fossero spari ripetuti. Un piccolo pezzo di piombo, appena più grande di uno dei bottoni della mia camicetta, è già penetrato tra le scapole indifese dell’uomo che mi ha voltato le spalle per raggiungere l’auto parcheggiata sul ciglio della camionabile. Senza un grido, lui rimane per un momento immobile; poi, stramazza lentamente tra le felci alte. Ora tutto è silenzio intorno a me. Gli alberi secolari hanno lo stesso aspetto di prima, il vento leggero che ne accarezza le cime non ha smesso di soffiare e dalla camionabile, appena oltre gli alberi che fanno da corona alla radura, non giunge alcun rumore. L’eco dello sparo si è spenta; è rimasto solo il suo odore, aspro, a coprire il profumo della ginestra che macchia di giallo il verde, altrimenti non interrotto, che mi circonda. Pochi secondi e tutto è ritornato a posto. No! Adesso ci sono anche altre felci scomposte, schiacciate dal corpo di lui, oltre quelle che ci hanno fatto da letto appena pochi minuti fa, quando ero ancora tra le sue braccia. Uno schiocco, l’odore acre dello sparo, un piccolo pezzo di piombo e quel corpo, tante volte amato, giace ora di nuovo tra le felci alte. Da solo. Dovrei scappare, dovrei sentire il cuore martellarmi in petto, l’emozione togliermi il fiato, la colpa travolgermi e, perché no, qualche lacrima velarmi lo sguardo. Nulla! Neppure il sollievo d’averlo fatto, di essermi liberata di lui, delle sue volgari risate, della sua arroganza, delle sue braccia forti, di quel barlume d’amore che talvolta mi è sembrato di leggere nei suoi occhi scuri.
Com'è stato facile! E com'è sproporzionato il risultato di quel gesto.
Solo una leggera pressione sul grilletto della pistola che lui portava sempre con sé e che mi ha lasciato in mano, voltandomi le spalle nell'ennesima dimostrazione del suo potere. L’ultima! Resto immobile, assente, a cercare nel silenzio che mi circonda un segno di normalità, il braccio inerte lungo il fianco, inconsapevole della pistola che ancora stringo in pugno. Poi, meccanicamente ripulisco l’arma con un lembo della camicetta, mi accosto al corpo di Paolo e la lascio cadere al suo fianco. Adesso devo rientrare in paese. Imbocco la via dei campi, quella stessa che ho percorso nella direzione opposta qualche ora fa per incontrare il mio uomo. Scendo giù per la campagna, attraverso la camionabile che qui e là interseca il mio cammino. Non incontro anima viva. Del resto, di domenica non ci sono contadini in giro e le rare automobili in circolazione, evidentemente, hanno altre destinazioni. Mi stupisce ancora la mia freddezza, quel gelo che sento dentro e, nel contempo, il sollievo che mi riempie il petto, la sensazione di libertà che la vaporosa gonna mi trasmette frusciandomi tra le gambe, al ritmo dei miei passi, in una carezza che sa di fresco, di indipendenza riconquistata. Respiro a pieni polmoni i profumi d’inizio estate che colora tutta la vallata a tinte forti, prepotenti. Ancora poche ore prima il mio corpo aveva bruciato di passione, nell'attesa delle sue mani, del suo pronto ardore. Sono contenta? Non saprei rispondere. Non è stato un gesto premeditato, tirare quel grilletto, non l’ho mai pensato consapevolmente; non ho analisi da fare: emotivamente ho agito ed emotivamente sento, adesso, di essermi lasciata alle spalle un pezzo di vita. E non lo rimpiango.
Acqua sotto i ponti

La chiamavano Littorina. Era un convoglio di pochi vagoni trainati dal primo, apparentemente non diverso dagli altri, che da qualche parte doveva nascondere un motore diesel. Quella tratta della linea Jonica non era ancora elettrificata, o forse era meglio dire non era elettrificata, ché non sembrava davvero ci fosse alcuna intenzione di farlo. L’unico binario solitario, steso sulla massicciata riarsa, sembrava messo lì più per segnare il limite delle spiagge sabbiose che costeggiava, piuttosto che per collegare i paesini che attraversava. La littorina vi rotolava a stento, mai sicura di raggiungere la Stazione successiva. Ad ogni sosta sembrava raccogliere le forze, ripartiva rumorosamente lanciando un lamentoso squillo nella calura pomeridiana e si lasciava alle spalle un altro, assonnato, borgo.
Faceva molto caldo. Un caldo afoso che incollava addosso gli abiti umidi. Fuori dal finestrino il mare, azzurro e fermo, era una tentazione irresistibile che aumentava il senso di calore dei passeggeri. Erano pochi, in verità, non più di una decina, tutti intrappolati nei propri pensieri.
Il maresciallo Carmine Vinci aveva dovuto fare più di quindici anni di servizio, prima che il Comando si arrendesse a fargli reggere una Stazione nella sua terra d’origine. Ma Vinci aveva sempre fornito prova d’attaccamento al dovere e rettitudine indiscussa… si poteva provare a mandarlo in Calabria, finalmente, anche perché non c’erano tanti sottufficiali capaci da spedire laggiù. Per essere un maresciallo era piuttosto giovane, non arrivava ai quaranta, e dentro la divisa si sentiva a proprio agio. Ed eccolo lì, sulla littorina asmatica, ad affacciarsi ogni volta che il treno rallentava, per il timore di saltare la Stazione d’arrivo.
S’accorse appena in tempo che era il momento di scendere. Dalla Stazione avrebbe dovuto proseguire con un’auto pubblica, se l’avesse trovata, o con una cavalcatura. La sua destinazione finale, un paesino alle falde dell’Aspromonte, distava ancora qualche decina di chilometri.
Vi giunse quasi a sera. I suoi uomini, un appuntato e quattro carabinieri, l’aspettavano in silenzio. Solo l’appuntato era più anziano di lui e nessuno aveva moglie. La piccola caserma si presentava bene, anche se di comandanti doveva averne visti passare parecchi. Si mise a letto stanchissimo. Domani avrebbe dovuto presentarsi alle varie autorità del paese: sindaco, parroco, farmacista, medico… no, il medico non l’avrebbe trovato, gli avevano detto al Comando di Compagnia, si sarebbe trattenuto per qualche tempo a Roma, dalla figlia.
Una vita, una chance

Calabria, febbraio 1970
L’uomo dietro il banco di vendita aveva un’espressione molto seria e gli occhiali da presbite, poggiati sulla punta del naso, la rendevano anche vagamente dottorale. Alzò lo sguardo e gli sorrise, come per incoraggiarlo ad avanzare:
“Buona sera!”
L’altro, di qua del banco, rispose: “buonasera” e, senza aggiungere nulla, gli porse la tela che voleva fare incorniciare.
Lui prese ad osservarla attentamente, con l’aria di chi si trova di fronte ad un problema da risolvere. Dal soffitto, dietro di lui pendevano bastoncini di legno di ogni lunghezza e colore: gialli, dorati, lisci, lavorati… Anche buona parte delle pareti sfoggiava la stessa tappezzeria. Pensoso, rigirava la tela alla ricerca della luce migliore per valutarla.
“Avete già un’idea di cosa cercate?”, gli chiese infine.
“Direi di no,” rispose, “fate voi!” Sorrideva appena, con aria vagamente imbarazzata, come se quella conversazione gli creasse disagio.
Il corniciaio stirò le labbra in un sorriso più aperto, di approvazione.
“Sapete, ogni tela ha bisogno della sua cornice, quella giusta intendo, che in qualche modo la completi: ci si deve trovare bene dentro”, aggiunse sempre rivoltando la tela tra le mani. “Non la si può costringere dentro confini che non senta propri. La cornice è definitiva!”, concluse lapidario.
Rimase ancora per qualche momento in silenzio, quindi si girò e scomparve, inghiottito da una porticina alle sue spalle.
C’era un vago odore di vernice e, qui e là, qualche cavalletto con il suo bel quadro in esposizione. Nessun rumore.
Non doveva essere divertente starsene lì tutto il giorno ad aspettare, pensò il cliente. In piedi tutta la giornata, poi! Ma... possibile? Cercò di sbirciare dietro il banco alla ricerca di qualcosa su cui ci si potesse poggiare: nulla! Quanto poteva rendere un lavoro di quel genere?
Il leggero scampanellio che segnalava l’apertura della porta precedette di un attimo l’ingresso di un altro cliente. Appena il tempo di lasciare insinuare nel relativo tepore del negozio l’alito pungente della fine di febbraio, ed un ticchettio leggero, irregolare, come esitante, riempì il locale. Passi femminili, giudicò, prima di girarsi. Si scambiarono un muto sorriso di saluto; lei si accostò al banco, quasi riluttante, e si dispose ad attendere.
Una storia tinta di bianco

Capitolo primo
Questura di Genova DIGOS
A
-Internosicurezza 555/224-555/op Roma
-Prefettura Genova
04042020 Cat E.2_/DIGOS/Sez. Info punto
OGGETTO: pacchi, plichi, buste e borse sospette.
Nella serata di ieri personale dipendente è intervenuto in questa via Dante, presso la sede della Banca d'Italia, ove era stata segnalata da personale dell'Arma Carabinieri la presenza di borse sospette posizionate ai lati del portone d’ingresso dell'edificio.
Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del gabinetto regionale di polizia scientifica, che hanno proceduto a mettere in sicurezza la zona interessata e, quindi, gli artificieri i quali, al fine di neutralizzare ogni eventuale meccanismo di innesco, hanno scaricato il cannoncino ad acqua contro gli involti sospetti. Questi ultimi, rimasti semidistrutti dall’acqua ad alta pressione, verosimilmente contenevano un numero imprecisato di brick di latte della Parmalat, del tipo Zymil ad alta digeribilità, con scadenza nei prossimi giorni. Da immediato sommario esame, il liquido presente all'interno dei brick parrebbe essere effettivamente latte; sono comunque in corso specifici accertamenti da parte della polizia scientifica.
Il gesto non è stato al momento rivendicato, né si sono rinvenute scritte in merito.
Sono attualmente al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della Banca.
Autorità giudiziaria informata dall'Ufficio Prevenzione Generale reati, intervenuto nell'immediatezza dei fatti.
Questore Vegliante.
*****
Tutta quella fatica per niente! Marzia Semenza, cronista free lance temporaneamente in forza al Secolo XIX, si era precipitata fuori dalla redazione come un fulmine, aveva bruciato due semafori e aveva piantata l'auto praticamente al centro della strada, per cosa? Delle inquietanti confezioni di latte!
La scena era stata pure divertente, alla fine, se si voleva guardare il lato comico della cosa: la strada chiusa da nastri rossi e bianchi; auto di Polizia e Carabinieri, lampeggianti accesi ad illuminare drammaticamente d'azzurro le vecchie mura delle case; due artificieri con tanto di pesantissima protezione e, a prudente distanza, una discreta folla di curiosi. Lei era riuscita a penetrare nella zona rossa calzando, prontamente, delle soprascarpe usa e getta come quelle usate dal personale della Scientifica sul luogo di un delitto. L’accorgimento l’aveva fatta passare per una “collega” agli occhi degli agenti impegnati nell’operazione, e aveva potuto scattare anche alcune fotografie, prima che il cannoncino ad acqua della squadra artificieri venisse scaricato contro i borsoni, e ne rivelasse il pallido contenuto.
Si era aspettata qualcosa di più drammatico. Qualcosa che potesse agguantare l’interesse dei lettori. E invece…Ma sì! Si incoraggiò tornando alla macchina, non era certo uno scoop, ma un pezzo per l’edizione dell’indomani ne sarebbe comunque venuto fuori. Poteva essere stato utile esserci. Magari con un titolo come "Allarme alla Banca d'Italia. Inquietante messaggio ancora da chiarire”, qualche copia in più si sarebbe venduta. Certo, lei aspirava ad affermarsi come cronista di nera, non come addetta alla rubrica "Mestoli in cucina”, e però, pensò, poteva costruire un pezzo tra il serio e l'ironico, mettere un po' in ridicolo l'intervento dei tutori dell'ordine e lasciare comunque sul lieto fine l'ombra di un inquietante avvertimento… di un folle? Un anarchico? O magari di Al Qaeda... Già, forse poteva provare a dare un significato al contenuto dei borsoni. I musulmani avevano regole alimentari particolari, dettate direttamente dal Corano. Chissà come veniva considerato il latte?
Non ebbe il tempo di completare la riflessione perché, alzando lo sguardo alla ricerca dell’auto, non la vide! Eppure, era sicura di averla lasciata all’altezza della rivendita di giornali. Possibile che ricordasse male! Si guardò intorno, ansiosa, e la riconobbe, laggiù in fondo alla strada, trascinata via dal carro attrezzi della municipale.
*****
Il rapporto del capo squadra artificieri lo fece sorridere. Certo molto meglio latte che materiale esplosivo. Un po' ridicolo, forse, tutto quell’ambaradan per delle confezioni di latte, ma certo preferibile ad un vero attentato. Appose la sua sigla sull'orlo in alto del foglio e stava già per scrivere “atti”, la magica parola che solleva ogni burocrate dall'onere di dare un corso amministrativo al documento su cui viene scritta, quando il dubbio gli attraversò la mente. Lui era il Capo di Gabinetto della Questura, a lui spettava la decisione di far vedere o meno quella carta al Questore, e metterla agli atti avrebbe privato quest’ultimo della possibilità di valutarne il contenuto, nel bene e nel male. E se si fosse trattato davvero di un avvertimento? Oddio, il latte era essenzialmente poco minaccioso, ma era pur vero che qualcuno aveva posti, o abbandonati, lì quei due borsoni. Un motivo doveva pur esserci! Poco significativo come avvertimento, certo, ma sembrava scarsamente probabile anche che si trattasse di refurtiva abbandonata. Cercò di immaginare la scena: una o due persone passano intorno alla banca, trascinando dei pesanti borsoni. Per quale maledetto motivo dovrebbero depositarne uno di qua e uno di là dei montanti del grande portone dell’edificio? Se, poi, era stata una sola persona, perché mai non li aveva lasciati uno accanto all’altro? la distanza tra i due borsoni non poteva assolutamente accreditare l'ipotesi di un precipitoso abbandono di refurtiva. Ci fossero state dentro delle armi, o sostanze tossiche, chimiche! Insomma, qualcosa potenzialmente minaccioso. Ma il latte! Non era neppure scaduto: si poteva persino bere.
“No! Tu non stai bene con la testa!” si disse, “ma guarda cosa stai elucubrando!”
Girò il foglio e lo inserii nel corriere che il capo avrebbe visto di lì a poco, appena lui avesse finito di esaminare anche gli altri documenti che l'archivista gli aveva sottoposti.
Basta latte! L’indomani mattina, a colazione, si sarebbe preparato un bel tè!
Cenerentola in tacco dieci
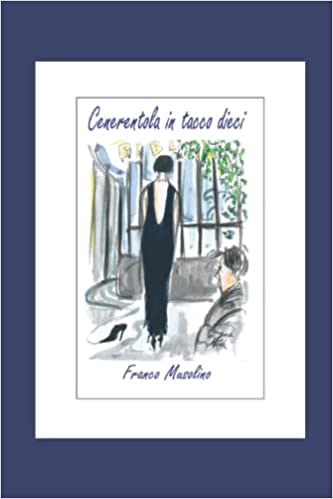
Prologo
Erano agganciate a una bacchetta della inferriata sul muro di cinta della biblioteca comunale, come fossero esposte in vetrina. Ma la vetrina non c’era, ed esse guardavano verso l’interno, affacciate sul cortiletto che separava il cancello dal portone d’ingresso, sollevato di qualche gradino.
Due scarpe da donna, nere, eleganti. Col tacco alto, da sera. Non erano scarpe per andare in biblioteca, quelle. Non ce le vedeva proprio sui gradini verso cui erano rivolte. No! Pretendevano lo scalone di una villa elegante, un ristorante alla moda, un teatro; e naturalmente, le gambe nervose di una sofisticata signora, snella e altera, col suo bell’abito aperto sulla schiena.
Carlo si arrestò, stupito, a osservarle, e poi si guardò intorno, per il caso che la proprietaria potesse essere ancora in vista. Ma non vide altro che una coda di auto, ferme al rosso del semaforo sull’incrocio con la via principale. Alzò lo sguardo verso il portone d’ingresso della biblioteca, ancora aperto, da cui filtrava la voce amplificata del conferenziere di turno. “Aschenez e la fondazione di Rhèghion, tra mito e storia millenaria”, recitava la locandina esposta in cima alla scala. Niente! Nulla che sembrasse poter avere un collegamento con le scarpe. Se ne ritrovò una in mano senza accorgersi di ciò che stesse facendo: era piccola, di pelle pregiata, morbida, accogliente; e lucida, come se fosse stata appena acquistata. Si guardò ancora intorno, e incrociò lo sguardo incuriosito, e malevolo, gli parve, di un uomo seminascosto da uno degli alberi che punteggiavano l’altro ciglio della strada. Sembrava di cattivo umore, come un marito che attenda, spazientito, la moglie impegnata in una conferenza, in biblioteca appunto, considerò. Evidentemente, poteva sopravvivere anche senza conoscere la storia della fondazione della città! Sorrise al pensiero, e rimise a posto la scarpa, riagganciandola all’inferriata, accanto alla compagna.
Riprese la via di casa, mentre una inquietudine nuova gli cresceva dentro. Era come se quelle scarpe abbandonate in bella mostra pretendessero qualcosa da lui. Fu tentato di tornare sui propri passi, e tirare diritto gli costò non poco.
Viveva da solo, Carlo Alfieri. Non avrebbe saputo dire se fosse stata una scelta consapevole quel celibato, mantenuto ad onta delle sollecitazioni della madre che avrebbe voluto vederlo “sistemato” prima di chiudere gli occhi. Così, quando fu entrato in casa, il suono dello scatto della serratura ne attraversò, indisturbato, gli ambienti vuoti e bui. Non era lontano dalla biblioteca, e forse dal balcone della cucina, si disse d’impulso, avrebbe potuto inquadrarla ancora. Non si sbagliava, infatti, constatò di lì a poco, affacciandosi all’esterno. Ma oramai era quasi calata la sera, e della biblioteca non riusciva a distinguere neppure l’inferriata. Figurarsi le scarpe!
Rientrò, chiudendosi alle spalle l’umidità della sera, ma non l’inquietudine.
Capitolo primo
Carlo Alfieri amava il proprio lavoro. Non era semplice, e gli provocava anche sofferenza, talvolta. Ma già alle scuole medie aveva deciso che da grande avrebbe fatto lo psicologo. Lo affascinava l’idea di poter aiutare le persone a vivere meglio. Aveva cominciato a fare pratica fin da allora, ascoltando le confidenze dei compagni, con discrezione e partecipazione umana. In verità, finite le medie, gli era passato per la testa anche di entrare in seminario, ma non aveva “sentito” una vera chiamata, e non poteva creare dei problemi esistenziali a sé stesso, ancor prima di cominciare a studiare come aiutare gli altri a risolverli.
Adesso, appena più che sessantenne, si sentiva professionalmente realizzato: il suo studio era molto stimato, e non era raro il caso che dovesse rifiutare nuovi pazienti, non solo perché erano tanti ma, e soprattutto, perché non riusciva a comprimere le sedute nei tempi stretti che un impegno più articolato avrebbe preteso. La sua prima regola era ascoltare, senza trasmettere alla persona che gli stava confidando i propri segreti alcun segno di premura, o di impazienza.
La sua discrezione era divenuta proverbiale. Curava in modo maniacale la privacy dei propri pazienti, ai quali il suo studio offriva una via di uscita differente da quella d’ingresso. Vi si accedeva da un trafficato androne comune anche ad altri studi professionali, e se ne usciva alle spalle, su un’altra scala, altrettanto frequentata. Al suo portone la targhetta d’ottone, sempre lucida, indicava solo nome e cognome, senza nessun titolo accademico.
Il suo consolidato celibato gli consentiva la massima libertà, quando non era al lavoro, ma non aveva tanti amici, perché aveva imparato a selezionarli con cura. Non che fosse un misantropo: era solo così impegnato a vivere le vite dei suoi pazienti, da restarne pressoché sazio. Questo aspetto della sua professione lo affascinava. Ogni volta che cominciava un trattamento, gli si spalancava davanti una nuova avventura. E si sentiva ricchissimo.
Le ristrettezze economiche dei primi passi lavorativi lo avevano costretto a fare a meno di una segreteria, e col tempo la necessità era diventata una scelta che assicurava ancor maggiore discrezione alla sua attività. Poi, l’avvento dell’informatica aveva fatto il resto e, da anni ormai, gestiva i propri appuntamenti con lo smartphone. Adesso la campanellina di una notifica gli ricordava che al primo, e unico, appuntamento pomeridiano mancavano solo trenta minuti; poco più del tempo che gli sarebbe occorso per raggiungere lo studio in anticipo rispetto alla signora Bernardi. Era una nuova paziente, indirizzata a lui da un comune amico a cui non aveva potuto opporre un rifiuto. Come per ogni prima seduta, si era riservato tutto il pomeriggio lavorativo. Aveva bisogno di stabilire un collegamento empatico che mal si sarebbe conciliato con l’incalzare di scadenze orarie; la signora avrebbe potuto parlargli, se ne avesse avuta voglia, fino a sera.
Lei, Daniela Bernardi, era nervosa. La seduta da un analista non la entusiasmava. Un uomo, poi! Ma Enzo Cafarelli, suo amico e medico di fiducia, era stato categorico: era ormai ora di abbandonare la terapia farmacologica che, seppur blanda, la sosteneva da quasi due anni. E se l’amico aveva toccato ogni punto sensibile per convincerla a fare qualche seduta di analisi, il medico era stato perentorio. Lei veniva da un divorzio molto doloroso, a tratti umiliante, e adesso se lo doveva lasciare alle spalle senza strascichi. Il dottor Alfieri era il miglior professionista della città, ed Enzo le aveva garantito che si trattava di persona molto delicata e discreta.
Adesso, salendo per le scale dello studio dello psicologo, Daniela avrebbe volentieri preso per il collo l’amico medico. L’aveva cacciata in una situazione che la metteva in imbarazzo ancor prima di cominciare! Suonò al campanello appena arrivata davanti alla porta dello studio, senza esitare, per resistere alla tentazione di dare buca.
La porta si aprì subito, come se qualcuno fosse rimasto dietro di essa in attesa solo del trillo del campanello.
Non se lo aspettava così! Nella sua immaginazione il dottor Alfieri era stato un occhialuto soggetto, pensoso, con tanto di barba e occhiali. Chi le aveva aperto, invece, era un signore alto e snello, sorridente, senza occhiali né barba. Sui cinquanta abbondanti, aveva giudicato.
Quasi sempre è come pare

Prologo
Non avrebbe saputo definirsi. Non ce n’era bisogno, del resto. Ma non riusciva a fare a meno di chiedersi che tipo di donna fosse diventata. Come fosse riuscita a escludere dalla propria vita quell’uomo, che pure le era padre; come era riuscita a cancellarne anche il ricordo fisico; come poteva sentirsi così indifferente alla sua sorte! E perché, invece, adesso il pensiero di lui si era insediato nel suo cervello, senza lasciare spazio ad altro.
Era tutta colpa del treno, si disse, e di quelle rotaie infinite che rallentavano lo scorrere del tempo. Le capitava sempre. La poltrona del vagone ferroviario dava automaticamente la stura alle sue riflessioni esistenziali.
Forse aveva ragione il suo ex fidanzato, che alla fine aveva alzata bandiera bianca di fronte ai suoi continui mutar di pelle. Ora allegra e leggera, addirittura superficiale nei suoi entusiasmi improvvisi, ora silenziosa, complicata, irritabile e musona, Linda Ferretti forse era solo una donna.
E Marco, il suo ex, solo un uomo!
Era arrivata alla soglia dei trenta, e aveva deciso da tempo di festeggiare il compleanno a Napoli.
Se lo meritava! Se l’era ripetuto anche quando, a distanza di due giorni dalla data fatidica, era giunta la telefonata dei Carabinieri, che la invitavano a presentarsi al Comando provinciale di Reggio Calabria. Ci sarebbe andata, naturalmente, ma non aveva nessuna intenzione di rinunciare a Napoli, a quel palcoscenico, a quel mondo, alla sua gente, a quella fantasia che colorava di azzurro anche il cielo più cupo!
Ci aveva lavorato per un paio di anni, appena laureata, quando ancora credeva che bastasse studiare per far bene le cose, e se n’era innamorata senza ritegno. L’aveva mantenuta nel cuore, quella città, anche quando la multinazionale farmaceutica per la quale lavorava aveva deciso di farla tornare al nord, alla sede di Milano.
La telefonata dei Carabinieri l’aveva messa in agitazione, anche se erano stati gentili, a tratti avrebbe detto addirittura cordiali. Le chiedevano di “favorire in Comando, senza fretta, ma quando avesse potuto.” Certo, l’avessero costruita al contrario, quella frase le avrebbe creato meno ansia, perché altro le sarebbe suonato “quando avesse potuto, ma senza fretta”.
Quell’invito, per quanto garbato, l’aveva turbata, e le aveva fatto tornare in mente di aver conosciuto il Prefetto di Reggio, un paio di anni prima, quando ancora era il Vice Prefetto Vicario di Milano.
All’epoca, avevano sviluppato un rapporto di stima professionale, ma anche molto cordiale, in nome del quale lei gli aveva promesso una telefonata, se mai si fosse trovata a passare da quell’estremo lembo d’Italia, e adesso cercava di convincersi di non essere andata troppo fuori dalle righe, chiamandolo davvero.
Pure lui era stato molto amichevole, forse anche per la differenza d’età, che li collocava in un rapporto quasi padre – figlia, le era venuto di pensare più volte: «insomma, è riuscita a pescare l’unico periodo di questo anno in cui non sarò in sede, dottoressa!» L’aveva bonariamente rimproverata, «spero che lei si trattenga sino al mio ritorno. Ad ogni buon fine, le manderò il numero di telefono del mio Capo di gabinetto, che potrà chiamare per ogni necessità, come se fossi io stesso. Spero di rivederla!» Aveva concluso, rammaricato.
Il treno filava via, di tanto in tanto sibilando tra gli scambi, ma ancora era lontana dalla meta.
Che donna sei? Si chiese, ancora. Le riaffiorò alla mente il motivo della telefonata dei Carabinieri, e cercò di scacciarlo pensando al proprio ultimo rapporto sentimentale. Sì, perché, in fondo in fondo, era stata lei a non lasciare scelta a Marco.
All’inizio l’aveva divertita osservarne l’aria interdetta che i suoi mutamenti d’umore gli stampavano in viso.
«Sei fantastica!» Osservava lui, con ammirazione, le prime volte. «Sei così imprevedibile…una continua sorpresa!»
Poi, nel giro di qualche mese, quella fantastica imprevedibilità si era evoluta in insopportabile schizofrenia, evidentemente. E Marco aveva presa la stessa strada dei suoi, per altro non numerosi, predecessori.
Sapeva di non avere un buon carattere, Linda, e avrebbe voluto correggerlo. Tuttavia, quando le passava per la testa quella riflessione, il finale non era mai scontato, perché doveva fare i conti con l’umore del momento che, se non già scontroso in partenza, quasi sempre virava al brutto in pochi secondi, forse proprio a motivo di quel pensiero.
Ed eccola ancora lì, sul treno per Napoli a cercare di leggersi dentro, prima dei trenta, e prima di rimettere piede in quella Calabria da cui si era allontanata a quattro anni, con la manina aggrappata a quella, forte e affettuosa, di zia Angela.
Quella di Roma era una “Stazione di testa”. Il treno non poteva attraversarla, come di solito accade per le Stazioni meno importanti. Era costretto a entrare e uscire, invertendo il senso di marcia.
Così, avevano sprecati minuti preziosi e, per quello che in quel momento le importava di più, adesso si trovava a viaggiare con le spalle al locomotore. Detestava viaggiare con le spalle alla direzione di marcia, perché le dava un vago senso di malessere che la costringeva a non guardare dal finestrino. Chiuse gli occhi. In fondo, se si fosse appisolata non sarebbe stato male: avrebbe accorciata la durata del viaggio!
Ma no! Nonostante quello fosse uno scompartimento business dove era espressamente vietato parlare o, peggio, telefonare, ad alta voce, c’era qualcuno in fondo al vagone, alle sue spalle, che non se ne curava più di tanto, e cercava di condurre lamentose trattative al telefono. Una voce baritonale, calda, eppure fastidiosa. Non c’erano dubbi che appartenesse al cosiddetto sesso forte.
Per istinto, sarebbe corsa a spiegare a quel villano che non poteva permettersi di disturbare gli altri viaggiatori, ma si sarebbe rovinata la giornata, si volle convincere, mentre indossava le cuffie dello smartphone per annullare il fastidio a suon di musica.
Avrebbe voluto dedicare un’occhiata sprezzante a quel bel tomo, prima di mettersi più comoda. Ma girarsi indietro, per incrociarne lo sguardo, gli avrebbe regalata troppa importanza, e inclinò al massimo lo schienale della poltrona, decisa a rilassarsi nonostante tutto.
*******
Il professore Martino quel cambio della direzione di marcia l’aveva atteso già dal momento in cui aveva messo piede sul treno. A Roma ci era arrivato piuttosto malconcio, “trascinato” in quell’innaturale andare, e adesso poteva finalmente spingere lo sguardo fuori dal finestrino senza sentirsi lo stomaco in bocca. Tirò un sospiro di sollievo.
Era consapevole che il proprio carattere peggiorava di pari passo col trascorrere del tempo, una forma elegante, o per lo meno non troppo cocente, per dire che stava invecchiando. Anzi, che era già invecchiato, gli impose la coscienza.
Da qualche anno era diventato irritabile; si spazientiva per un nonnulla, tendeva a riporre gli oggetti che gli passavano per le mani nei posti che lì per lì gli sembravano i più indicati per ritrovarli al momento in cui fossero stati necessari, e regolarmente ne perdeva la memoria. C’era poco da prendersi in giro con penosi eufemismi! Ma non era questa circostanza a dargli fastidio. No! Era lo spreco di tempo che non riusciva più a tollerare.
Aveva vissuto costantemente concentrato sul proprio impegno professionale, e i giorni gli erano scivolati tra le dita senza che riuscisse a percepirne il valore.
Adesso, gli era chiaro che tante cose erano perdute, irrimediabilmente.
Guardandosi intorno, provava spesso pena per il prossimo di cui incrociava i passi, protagonisti e comparse tutti intenti a correre, a cercare di concludere ciò che stavano facendo, ignari dell’approssimarsi dei titoli di coda.
Quando era andato in pensione, si era ripromesso di usare quel segmento di “età libera”, dal lavoro, e nel suo caso anche dal bisogno economico, per godere finalmente di tutti quei piaceri di cui aveva rinviata la soddisfazione. Ma aveva dovuto prendere atto che la libertà esiste solo se, in parallelo, esista uno stato non libero, e che, come il giorno con la notte, aveva bisogno del suo contrario per valere qualcosa. Altrimenti, spesso era solo noia.
Perciò, si era imbarcato su quel Frecciarossa alla volta della Calabria.
Andava a trovare il caro amico di un tempo condiviso a Milano, anni prima. Corrado gli aveva promesso di fargli conoscere il “Grande Sud”, e lui sapeva che avrebbe mantenuta la parola.
In realtà, quel viaggio aveva anche un secondo obiettivo, forse meno divertente di zingarate turistiche, ma certamente assai stimolante: era stato autorizzato dal direttore della locale casa di reclusione a tenere una serie di conversazioni con quei detenuti. Lo aveva già fatto nei penitenziari milanesi, e ne aveva tratta una grande soddisfazione.
Il treno viaggiava in orario, ma lui cominciava già a osservare dal finestrino il mutare del paesaggio alla ricerca del mare, impaziente di raggiungere la meta.
Cercò di cacciare in fondo alla mente i pensieri negativi, che sprecavano ancora una volta il suo tempo, e si concentrò sulla ragazza seduta quasi di fronte a lui, una fila di sedili più in là.
Si sarebbe pure potuto sbagliare, si disse, ma aveva l’impressione che non avesse accolto col suo stesso piacere il dietro front del treno. Inclinava lo schienale della poltrona alla ricerca di una diversa posizione, più comoda, o forse stava solo cercando di rilassarsi al suono delle cuffie, magari per proteggersi dalla voce maleducata che proveniva dal fondo del vagone.